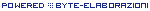« indietro
Kukjin Kim, Dante e le sue opera in Corea, 1897-2021
(pp. 27-30)
In Corea, Dante Alighieri (1265-1321) è ritenuto uno dei più grandi autori di tutti i tempi, principalmente grazie alla fama di cui gode la sua opera più conosciuta, la Divina Commedia, che offrì un contributo considerevole alla letteratura e alla lingua italiana. Egli, infatti, già a partire dai primi anni del Novecento, cominciò a venire sopranominato dagli studiosi coreani «divino poeta» (sisŏng, 詩聖) anche dagli studiosi coreani, che gli riconoscevano inoltre il merito di aver dato lustro alla lingua vernacolare italiana[1]. Nonostante ciò, bisogna ammettere che la conoscenza di Dante e le condizioni degli studi danteschi in Corea risultano meno approfondite rispetto agli altri paesi dell’Asia orientale, come in Cina e in Giappone.
A tal proposito, si rilevano due principali ragioni. In primo luogo, l’isolamento della Corea dall’Occidente fino agli ultimi decenni dell’Ottocento indusse a ‘importare’ quasi esclusivamente dal Giappone, nei primissimi anni della ‘apertura’, le conoscenze provenienti dal mondo occidentale, soprattutto i classici della letteratura. Inoltre, la colonizzazione della Corea da parte dell’Impero giapponese tra il 1910 e il 1945 fece perdurare tale situazione per circa mezzo secolo[2]. In secondo luogo, poiché le prime traduzioni delle opere principali di Dante in coreano ebbero inizio solo dagli anni Cinquanta del Novecento, i lettori interessati e gli studiosi, che non conoscevano l’italiano, soffrivano la mancanza di un contesto accademico adeguato, ed erano impossibilitati a interpretare i testi danteschi e a condurre analisi di qualsiasi tipo. In altre parole, nonostante la fama e l’importanza di Dante fossero già note, le basi erano insufficienti e vennero sviluppate solo più tardi.
In questa sede, dunque, considerando la situazione generale in Corea, si intende passare in rassegna le prime conoscenze su Dante, la traduzione delle sue opere e gli studi danteschi durante il periodo che va dal 1897 al 2021, ovvero da quando apparve per la prima volta il nome di Dante nei testi coreani sino al 700° anniversario della sua morte.
Il Poeta, già nella prima traccia documentaria in Corea che risale il 1897, venne presentato come uno dei principali scrittori di lingua volgare della letteratura occidentale. La documentazione in oggetto è un articolo pubblicato sulla 15° edizione del Bollettino dell’Associazione dell’Indipendenza[3] in cui l’autore mise il rilievo l’uso della lingua vernacolare:
[…] Nei Paesi dell’Europa occidentale, dopo il loro consolidamento, si svilupparono nelle proprie lingue madri la filosofia, l’algebra e la fisica, apparvero così personaggi come Chaucer, il divino poeta per l’Inghilterra, e Dante, il poeta immortale dell’Italia […][4].
Spinta dalla volontà di introdurre nuovi elementi culturali che provenissero al di fuori dall’Asia orientale, la Corea volle adottare una nuova modalità per l’istruzione e lo studio in generale. A tal riguardo, venne proposto l’uso ufficiale dell’han’gŭl, l’alfabeto coreano, nella lingua scritta in luogo dei caratteri cinesi. Dante, che aveva anzitempo adottato l’italiano per le sue opere, sostituendo il latino, avrebbe potuto ispirare in parte questo cambiamento.
Durante gli anni Venti del Novecento, Dante venne letto e conosciuto in modo più approfondito in Corea. Gli intellettuali e gli studiosi del tempo, come ad esempio Sin Ch’aeho (1880-1936), uno storico nazionalista, si dedicarono a presentarne non solo la letteratura ma anche il pensiero politico attraverso la sua vita e le sue opere, come la Divina Commedia ma anche la Vita Nuova e De Monarchia[5]. A partire dagli anni Trenta, invece, si possono individuare riferimenti più specifici rispetto ad alcuni temi della letteratura dantesca, come nel caso dell’‘amore libero’ a cui venne dato maggiore risalto che non alla coscienza morale e filosofica[6].
Gli studi danteschi in Corea, che fino alla prima metà del Novecento si limitavano a riprodurre dalle ricerche svolte dai giapponesi[7], avrebbero raggiuto un punto di svolta con le pubblicazioni delle traduzioni in coreano. La prima edizione coreana di Dante risale al 1957, quando, per mano di un prete cattolico di nome Choi Minsun (1912-1975), fu tradotta per la prima volta per intero la Divina Commedia[8]. Nonostante si ritenga che egli, con ogni probabilità, abbia svolto il suo lavoro ritraducendo l’opera dallo spagnolo in coreano[9], si trattò comunque di un passo significativo per la ‘fortuna’ di Dante in Corea in quanto prima di tale data si poteva contare soltanto su due canti del Paradiso tradotti dalla lingua giapponese nel 1926[10]. La traduzione di Choi è ben nota per la sua bellezza ed eleganza poetica, pur avendo ricevuto una serie di critiche dovute alla mancata accuratezza nella scelta di alcuni termini specifici[11].
Il desiderio di ‘leggere’ e ‘comprendere’ Dante a partire dalla lingua originale, si è concretizzato dagli anni Settanta. Era nel 1971 che Lim Myongbang, professore del Dipartimento di Storia della Inha University, pubblicò la prima edizione del capolavoro di Dante tradotto direttamente dall’italiano. Altri italianisti in Corea, successivamente, si sono dedicati alla traduzione della stessa opera: come Hoe In e Han Hyeong-Kon, docenti del Dipartimento di Italianistica della Hankuk University of Foreign Studies, che hanno tradotto rispettivamente nel 1974 e nel 1978[12]. L’esistenza di un’ulteriore ritraduzione della Divina Commedia dall’inglese per mano del noto traduttore Yu Young, nonché le diverse edizioni rivedute dell’opera, testimoniano il grande e costante interesse sul capolavoro di Dante[13].
La Divina Commedia, da quel momento, rimaneva costantemente tra i classici della letteratura occidentale più amati e studiati dai coreani: non mancano difatti versioni rivedute, tascabili, nuove edizioni accademiche e critiche o ancora quelle versioni che adottano un linguaggio adatto ai lettori più piccoli. Nel 2007 vengono pubblicate due nuove traduzioni dagli studiosi di italianistica: Kim Woon-Chan, professore di letteratura italiana della Daegu Catholic University e Park Sangjin, professore del Dipartimento di Italianistica della Busan University of Foreign Studies[14]. Quest’ultimo, inoltre, ha aggiunto alla sua edizione un sottotitolo, «La Commedia di Dante Alighieri», ritenendo che il titolo dell’opera tradotto in coreano, Sin’gok, letteralmente «le canzoni divine», non riflette adeguatamente il significato di «commedia» che intendeva Dante[15].
Le traduzioni delle opere dantesche in coreano, certamente, non sono limitate solo alla Divina Commedia. Già nel 1972, per esempio, la sua De Monarchia è stata tradotta da Seong Yeom, professore di Filosofia e ambasciatore presso la Santa Sede (2003-2007)[16]. Inoltre, nel 2005, i lettori coreani hanno finalmente avuto l’occasione di leggere Vita Nuova grazie a una ritraduzione dall’inglese[17]. Non da ultimo, va ricordata la traduzione in coreano del Convivio, un’altra opera importante ma incompleta di Dante, uscita nel 2010, grazie al lavoro di Kim Woon-Chan[18].
Le traduzioni in coreano delle opere dantesche hanno incentivato non solo la diffusione della conoscenza di Dante ma anche gli studi danteschi in Corea. Già a partire dagli anni Sessanta, diversi studiosi si sono dedicati allo studio di opere come Vita Nuova e De Monarchia[19]. A partire dal 2000, un accurato lavoro di esegesi del capolavoro dantesco viene condotto da un gruppo di studiosi sull’unica rivista di Italianistica in coreano, It’alliaŏ Munhak [Lettere italiane][20]. Si nota che i traduttori stessi della Divina Commedia hanno pubblicato una serie di articoli che trattano vari aspetti delle opere, dai commenti al testo all’analisi puntuale di elementi linguistici, artistici e filosofici[21]. Inoltre, alcuni storici si sono occupati sulla reputazione e la percezione di Dante tra gli umanisti fiorentini del Trecento e Quattrocento[22].
Si può pensare che la tradizione degli studi danteschi relativamente debole in Corea, d’altro canto, possa ancora beneficiare di ampi margini di sviluppo e di reinterpretazioni con prospettive del tutto inedite. Infatti, l’interesse verso Dante da parte sia del mondo accademico coreano sia dei lettori coreani è ancora forte. Recentemente, per esempio, Kim Woon-Chan, uno dei principali traduttori di Dante, ha pubblicato una versione riveduta della Divina Commedia in un unico volume[23]. Nel 2021, i musicisti del Dipartimento di Musica Coreana della Seoul National University hanno prodotto uno spettacolo di P’ansori, un genere di narrazione musicale coreana, eseguendo una originale reinterpretazione della Divina Commedia per l’occasione della 700° anniversario della morte di Dante[24]. L’eredità di Dante, dunque, risplende ancora nel Paese del Calmo Mattino dove egli rappresenta un’inestimabile fonte d’ispirazione e arricchimento culturale.
[1] Per la trascrizione dei termini in lingua coreana, è stato adottato il sistema McCune-Reischauer tranne i nomi degli studiosi contemporanei e delle università, i quali vengono trascritti secondo la romanizzazione scelta da essi.
[2] Per una descrizione generale su questo aspetto della storia coreana, si invita a consultare i seguenti: Maurizio Riotto, Storia della Corea, 2° ed., Milano, Bompiani, pp, 288-314 e 359- 371; Bruce Cumings, Korea’s Place in the Sun. A Modern History, 2° ed., New York, Norton & Company, pp. 86-184.
[3]Haeyŏng Shin, Hanmunja-wa Kungmunja-ŭi Sonik Yŏha [Pro-fitti e perdita dei caratteri cinesi e quei coreani], «Bollettino dell’Associazione dell’Indipendenza [Tae Chosŏn Tongnip Hyŏphoe Hoebo]» 15 (1897), pp. 10-3.
[4]Ibid., p. 11.
[5] Citato da Byung-chul Kim, Han’guk Kŭndae Sŏyang Munhak Saipsa Yŏn’gu [Studi sull’introduzione della letteratura occidentale nella Corea moderna], Seul, Ŭllyumunhwasa 1998, pp. 725-6.
[6]Ad esempio, l’amore di Dante verso Beatrice venne considerato come un motore della composizione letteraria dell’autore: «se non ci fosse l’amore con Beatrice, la Divina Commedia di Dante non sarebbe potuto creare». Pisŏk Chŏng, Sarang [L’amore], «Samch’ŏlli [Tremilla ri]» 12.7 (1940), p. 181.
[7] Sangjin Park, Han’guk Kŭndae Munhak-ŭi Tant’e Suyong Yŏn’gu [The Aspects of Reception of Dante Alighieri in Modern Korean Literature], ≪Pigyo Munhak [Comparative Literature] ≫ 41 (2007) pp. 309-46, in particolare pp. 330-8.
[8]Dante Alighieri, Sin’gok [Divina Commedia], traduzione in coreano di Minsun Choi, Seul, Ŭllyumunhwasa 1960.
[9]Il traduttore non specifica la copia originale ma si pensa che egli ha tradotto dall’edizione spagnola. Cfr. Hyeong-Kon Han, Tant’e Munhak-ŭi Hyŏnjuso [La fortuna di Dante in Corea], ≪It’alliaŏ Munhak [Lettere Italiane]≫ 14 (2004), pp. 201-22.
[10]Chŏn Yŏngt’aek pubblico 2° e 4° canto del ≪Paradiso≫ della Divina Commedia in coreano sul 6° edizione della rivista Yŏnhŭi del 21 maggio 1926.
[11]Woon-Chan Kim, Sin’gok-ŭi Pŏnyŏk-e Taehayŏ [Sulle traduzioni della Divina Commedia], ≪It’alliaŏ Munhak [Lettere Italiane] ≫ 24 (2008), pp. 23-51.
[12]Dante Alighieri, Sin’gok [Divina Commedia], traduzione in coreano di Myongbang Lim, Seul, Donghwa Ch’ulpan’gongsa, 1971; Dante Alighieri, Sin’gok [Divina Commedia], traduzione in coreano di In Heo, Seul, Dongsŏ Munhwasa, 1974; Dante Alighieri, Sin’gok [Divina Commedia], traduzione in coreano di Hyeong-Kon Han, Seul, Samsŏng Ch’ulpansa 1978. Tutti i traduttori hanno specificato che l’originale era in italiano.
[13]Dante Alighieri, Sin’gok [Divina Commedia], traduzione in coreano di Young Yu, Seul, Chŏngumsa 1972.
[14]Dante Alighieri, Sin’gok [Divina Commedia], traduzione in coreano di Unch’an Kim, 3 voll., Seul, Yŏllinch’aektŭl 2007; Dante Alighieri, Sin’gok. Tant’e Alligieri-ŭi K’omedia [La Divina Commedia di Dante Alighieri], traduzione in coreano di Sangjin Park, 3 voll., Seul, Minŭmsa 2007.
[15]Il termine ≪Sin’gok≫, difatti, era la traduzione di quello giapponese (神曲, しんきょく) ed era gia diffuso sin dalla prima metà del Novecento. Sul problema di tradurre il titolo della Divina Commedia in coreano, si rimanda a Park, Tant’e Suyong Yŏn’gu, in particolare pp. 325-6 e 338-40. Invece, per la traduzione dell’opera in generale, si rimanda Unch’an Kim, Sin’gok-ŭi Pŏnyŏk-e Taehayŏ [Tradurre la Divina Commedia], ≪It’alliaŏ Munhak [Lettere italiane]≫ 24 (2008), pp. 23-51.
[16]Dante Alighieri, Chechŏngron [De Monarchia], traduzione in coreano di Yeom Seong, Seul, Ch’ŏrhakkwa Hyŏnsilssa, 1972. L’edizione riveduta e stata pubblicata nel 2009 con annotazioni dello stesso traduttore.
[17]Dante Alighieri, Saeroun Insaeng [Vita Nuova], traduzione in coreano di Woosu Park, Seul, Minŭmsa 2005.
[18]Dante Alighieri, Hyangyŏn [Il Convivio], traduzione in coreano di Woon-Chan Kim, Seul, Nanam 2010.
[19]Per i primissimi studi danteschi in corea, si può citare i seguenti: Sanggŏn Paek, Tant’e-ŭi Chŏngch’i Sasang [Dante’s Political Thought], ≪Pŏpchŏng Nonch’ong [The Law & Public Administration Review]≫, 11.1 (1965), pp. 7-17; In Hŏ, Tant’e-ŭi Sinsaeng-e Kittŭrin yŏinsong [Praise for Women in Vita Nuova of Dante], ≪Han’guk Oegugŏ Daehakkyo Nonmunjip [Bulletin of Hankuk University of Foreign Studies]≫ 11.1 (1978), pp. 111-29. Recentemente, anche Ii Sang Yeob ha pubblicato uno studio sulla Vita Nuova: Sang Yeob Ii, Tant’e-ŭi Saeroun Sam Yŏn’gu [Un’osservazione su Vita nuova di Dante Alighieri], ≪It’alliaŏ Munhak [Lettere italiane]≫ 47 (2016), pp. 109-39.
[20]Per la situazione generale riguardo all’italianistica in Corea, si veda un articolo scritto in italiano da Ii Sang Yeob, L’insegnamento dell’italiano e la situazione attuale dell’Italianistica in Corea, ≪It’alliaŏ Munhak [Lettere italiane]≫ 33 (2011), pp. 169-93. Per la traduzione delle opere italiane in Corea, si veda Unch’an Kim, It’alliaŏ T’eksŭt’ŭ-ŭi Han’gugŏ Pŏnyŏk 30 Dante e le sue opere in Corea, 1897-2021 LXVI-LXVII 01-02/2022 Dante fuori di sé Hyŏnhwang [Situazioni attuali della traduzione coreana dei testi italiani], ≪It’alliaŏ Munhak [Lettere Italiane]≫, 27 (2009), pp. 41-64.
[21]Park Sangjin ha condotto numerosi studi su Dante, coprendo diverse tematiche che va dalla lingua e amore fino alla musica ed etica: Sangjin Park, Tant’e Sin’gok Yŏn’gu. Kojŏn-ŭi Pop’yŏnsŏng-gwa T’aja-ŭi Kamsusŏng [Uno studio sulla Divina Commedia di Dante. Universalità del classico e sensibilità per gli altri], Seoul, Ak’anet 2011; Sangjin Park, Tant’e-ŭi Sarang: Sŏng-gwa Sok-ŭi Kyoch’a [Dante in Love: Association of the Sacred and the Profane], ≪It’alliaŏ Munhak [Lettere italiane]≫, 40 (2013), pp. 91-139; Sangjin Park, P’osŭt’ŭ Pabel Ŏnŏ: Tant’e-ŭi Munhak Ŏnŏ-ŭi Kich’o [Post-Babel Language: A Basis of Dante’s Literary Language], ≪It’alliaŏ Munhak [Lettere italiane]≫, 42 (2014), pp. 137- 92; Sangjin Park, Kiwŏn-ŭi Moksori: Tant’e-ŭi Sin’gog-ŭl Ingnŭn Han Panghyang [The Voice of Origin: A way of Reading Dante’s Comedy], ≪Tongsŏ Inmun [Journal of East-West Humanities]≫, 8 (2017), pp. 43-78; Sangjin Park, “Kŭdae-ga Chojŏrhago Match’usin Chohwa”: Tant’e-ŭi Sin’gok-e Nat’anan Ŭmak-kwa Kuwŏn [≪L’armonia che temperi e discerni≫: Music and Salvation in Dante’s Comedy], ≪It’alliaŏ Munhak [Lettere italiane]≫, 52 (2017), pp. 63-117; Sangjin Park, Tant’e-ga Saegyŏnaen Chagi Chis-iŭi Ŏnŏ: Chamjaesŏngŭi Yulli [A Language of Self-Reference in Dante’s Comedy: Ethics of Potentiality], ≪It’alliaŏ Munhak [Lettere italiane]≫, 63 (2021), pp. 1-28. Tra i diversi studi di Ii Sang Yeob se ne deve menzionare almeno due sull’analisi dei due canti dell’Inferno: Sang Yeob Ii, Tant’e-ŭi Sin’gok che 1 kok Yŏn’gu [Una lettura del primo canto della Divina Commedia], ≪It’alliaŏ Munhak [Lettere italiane]≫, 51 (2017), pp. 101-22; Ii Sang Yeob, Tant’e-ŭi Sin’gok Chiokp’yŏn che 5 kok Yŏn’gu [Study on Hell V of the Comedy of Dante Alighieri], ≪It’alliaŏ Munhak [Lettere italiane]≫, 64 (2021), pp. 111-34. Per il Convivio, si nota prima di tutto delle ricerche importanti condotte dal traduttore di esso: Woon-Chan Kim, Tant’e-ŭi Hyangyŏn-gwa Sogŏ Kaenyŏm [Dante’s Convivio and his Idea on the Vernacular], ≪Oegunk Munhak Yŏn’gu [Foreign Literature Studies]≫, 28 (2007), pp. 72-94; Woon-Chan Kim, Hyangyŏn-gwa Tant’eŭi Munhakchŏk Nojŏng [Convivio e l’itinerario letterario di Dante], ≪It’alliaŏ Munhak [Lettere Italiane]≫, 26 (2009), pp. 1-29. Anche Han Sungchul ha fatto diversi studi sulla Divina Commedia e il Convivio: Sungchul Han, Kŭrisŭ Munhwa-ŭi Kyesŭngja-rosŏŭi Tant’e Yŏn’gu: il Convivio-wa Sin P’ŭllat’on Juŭi [Lo studio su Dante come continuatore della cultura greca antica], ≪It’alliaŏ Munhak [Lettere Italiane]≫, 44 (2015), pp. 257-77; Sungchul Han, Yŏngjijuŭija-rosŏŭi Tant’e Yŏn’gu: Hyangyŏn-gwa Sin’gok-ŭi Yŏnokp’yŏn-ŭl Chungsimŭro [A Study on Dante as Gnostics], ≪Pigyo Munhak [Comparative Literature]≫, 79 (2019), pp. 283-306.
[22]Byung-Chul Lim, Tant’e-ŭi Munhwajŏk Yusan-e kwanhan Pok’ach’io-wa P’et’ŭrarŭk’a-ŭi Sumgyŏjin Nonjaeng [The Hidden Polemic between Bocaccio and Petrarca concerning Dante’s Cultural Legacy] ≪Sŏyang Chungsesa Yŏn’gu [Journal of Western Medieval History]≫, 34 (2014), pp. 183- 215; Kukjin Kim, Tant’e-wa Siminjŏk Hyumŏnijŭm [Dante and Civic Humanism], ≪Sŏyang Jungsesa Yŏn’gu [Journal of Western Medieval History]≫, 35 (2015), pp. 167-94.
[23]Dante Alighieri, Sin’gok [La Divina Commedia], traduzione in coreano di Woon-Chan Kim, Seul, Yŏllinch’aektŭl 2022.
[24]Uno spettacolo di ‘Pan Drama (P’ansori)’ intitolato ≪Facce dell’Inferno di Dante≫ e stato eseguito da Eunhye Jung, sotto la regia di Sangman Kim presso Dipartimento di Musica Coreana, Seoul National University nel 2021. Si invita al seguente link per la versione sottotitolata a cura di Kukjin Kim e Valeria Ruscio: https://youtu.be/VoK63kEAdzA.
¬ top of page